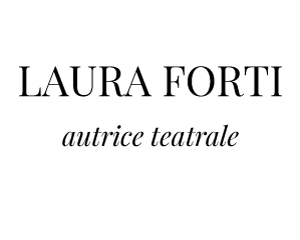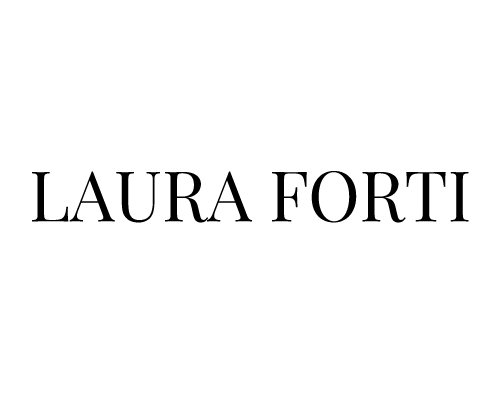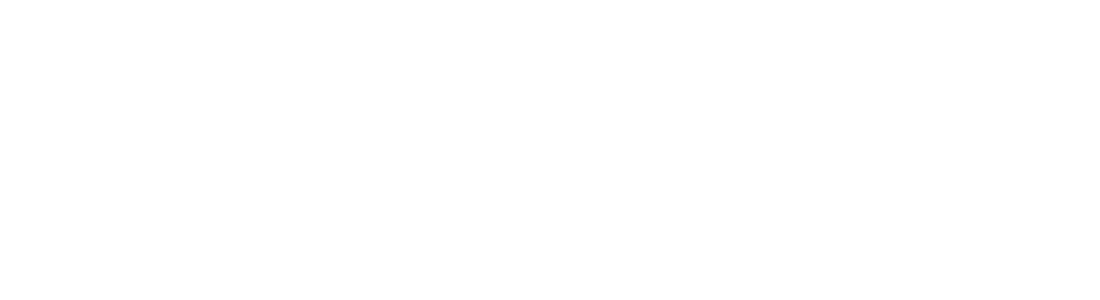Papotschka
Scrivere un monologo sulla vicenda di Svetlana Allilueva, la figlia di Stalin, è un’operazione complessa, una sfida. E’ come comporre un puzzle, fatto da tessere differenti per forma e dimensione: ci sono molti pezzi che apparentemente non combaciano, tante Svetlane, fotografate in diversi momenti dell’esistenza. C’è la Svetlana bambina, Svetlana Stalina, il “passerottino” o la “padroncina”, adorata dal padre, che si identifica in lui al punto di copiarne le pose autoritarie nelle fotografie, in costante ricerca della sua approvazione, che vive l’infanzia sullo sfondo dei maestosi paesaggi naturali della Russia; c’è la Svetlana adolescente che scopre la propria femminilità e i primi amori e per questo viene allontanata dagli affetti paterni e considerata traditrice e ribelle, la giovane inquieta che viene a sapere quasi per caso che la madre non è morta per una malattia come le è sempre stato detto ma suicida, forse vittima indiretta del regime di Stalin, disgustata dal crollo degli ideali in cui lei stessa aveva sperato. C’è la donna spaventata che cambia nome in Alleluieva, e sente di perdere potere e identità dopo la scomparsa del dittatore e l’incarcerazione del fratello Vassilj, c’è la madre che abbondona i figli ed è disposta allo strappo pur di fare il grande salto in America a ricominciare una nuova vita, abbracciando un sogno di libertà. C’è alla fine Lana Peters, la moglie dell’architetto, che cerca di ricostruirsi una famiglia in un contesto normale, medio borghese, nella provincia del Wisconsin e finisce per morire da sola in un ospizio. Ma la stranezza più grande è che, una volta messi insieme, per ironia della sorte, i pezzi del puzzle non ci restituiscono il vero volto di questa donna alla continua ricerca di sé stessa, non compongono cioè un’identità completa e definita, ma, quasi per una magia oscura, la riframmentano all’infinito in uno specchio rotto che riflette un’altra figura, un’ombra ricorrente, un fantasma: quello di Stalin, quel padre ingombrante, ferocemente amato e odiato, del cui nome, per sua stessa ammissione, Svetlana si è sempre sentita prigioniera.
Il testo è stato scritto in collaborazione con l’attrice Karina Arutyunyan.
In due righe:
Mi chiamo Svetlana e sono una bambina speciale. Svetlana non è un nome comune. Olga è un nome comune, Masha, Helena, ma Svetlana no. Prima nessuno si chiamava così. Adesso c’è addirittura una bambola. Quando sono nata io, mio padre ha pianto di gioia. Mi ha sollevato e ha detto: ecco la mia principessa. Anche mio padre è speciale. Il suo nome vuol dire acciaio, perché è forte. E’ talmente speciale che è dappertutto. Negli uffici, nelle piazze, nelle scuole. Ci sono tante statue come lui. E’ talmente speciale che comanda tutti. E’ il padre di tutti e ci vuole bene. Parla dall’alto, dal centro della piazza e noi lo stiamo a sentire col naso all’insu anche se fa freddo, anche se nevica. La strada si riempie di bandiere, di soldati. Tutti portano garofani rossi e la sua fotografia. Battono le mani. Anche sulle caramelle c’è la sua faccia. Le vecchie piangono, suonano i tamburi. Gli zii vanno a cavallo. L’altro giorno c’era perfino un signore sui trampoli e una bambina ha portato un mazzo di fiori. Mio padre ha stretto la mano ai suoi genitori e ha messo una medaglia sui loro vestiti. Io credo che lui sia il padre anche di quella bambina, anche di quei genitori, anche del signore sui trampoli. Lui è il padre di tutti.