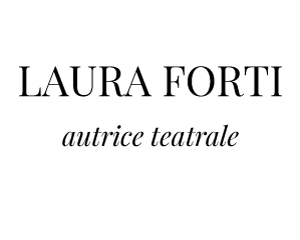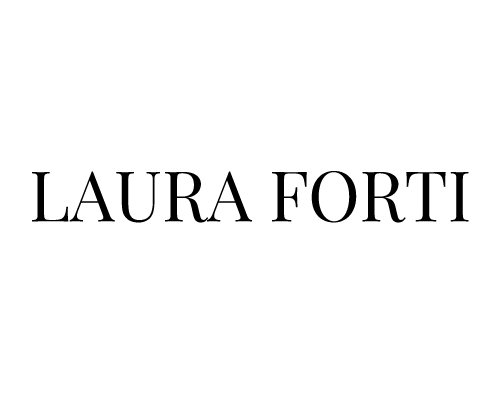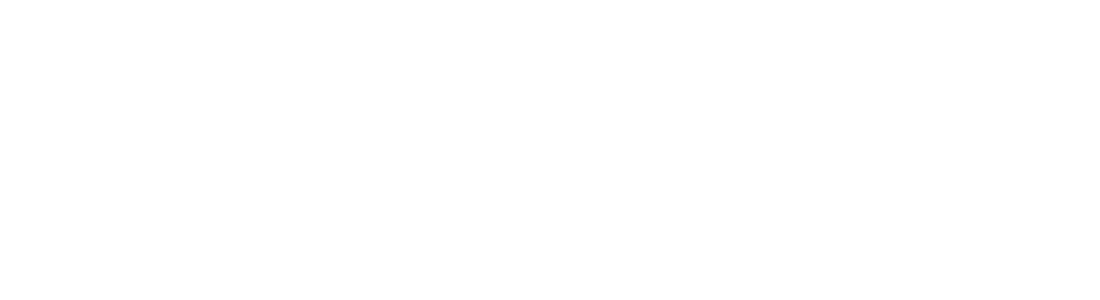I Cannibali
Ne “I cannibali” un gruppo di discendenti di “padri” uccisi ad Auschwitz , con l’’aiuto di due anziani sopravvissuti, tenta di ricostruire l’’ultima notte di vita dei genitori che, stremati dalla fame decidono di mangiare il corpo di un compagno ucciso per sbaglio durante una lotta per un tozzo di pane. I figli interpretano sé stessi ed i padri, in un continuo gioco di identificazione/differenziazione. Si capisce subito, fin dalla dedica che Tabori mette in epigrafe (in memoria di Cornelius Tabori, morto ad Auschwitz, uomo di scarso appetito) che siamo all’interno di una terapia collettiva e che l’autore, coinvolto in prima persona per aver perso il padre – che appare nel testo per pudore con il nome di “Zio”- ci invita a prendere parte ad un rito luttuoso che somiglia ad una messa nera: il mangiare dei protagonisti è metafora di un complesso rapporto con una memoria indigeribile. “I Cannibali” non lascia un attimo di tregua allo spettatore, chiedendogli un coinvolgimento emozionale totale ed attivo. E anche il traduttore ha il suo bel daffare, per assolvere a questo compito e mantenere alta la tensione. Intanto, anche se Tabori scrive nell’ inglese “piano” di chi ha adottato una lingua non sua (dice con ironia di avere una lingua madre, l’ungherese, una lingua padre l’inglese e una lingua zio il tedesco), il linguaggio è denso, complesso, si apre in squarci poetici improvvisi per poi riatterrare nell’orrore della situazione di partenza. Ci sono numerosi termini yiddish, perché Zio Tabori, l’uomo di fede del gruppo, rappresenta il mondo della tradizione ebraica dell’est e li ho volutamente lasciati in originale nel testo perché tradurli sarebbe impossibile e perché, offrendo un termine equivalente, si smarrirebbe quello struggente senso di perdita e di nostalgia dolorosa per un universo di saggezza e di umanità cancellato dalla strage. Ma quello che colpisce di più in quest’opera, e che, se vogliamo, la rende ancora più complessa da restituire, è il tono surreale, anti-naturalistico, perfino comico, che Tabori usa per descrivere il mondo del lager. Un tono che è sempre in equilibrio tra il ridicolo e l’orrore. Naturalmente si tratta di un riso tragico, di un humour noir che colpisce lo stomaco, ma, fin dall’inizio l’atmosfera rifugge qualsiasi intento realistico (che sarebbe del resto intollerabile) per protendere verso un clima straniato e allucinante. D’altra parte, come sarebbe possibile rappresentare Auschwitz in termini realistici, senza essere ingenui, offensivi, inefficaci? E così Tabori, memore della lezione di Brecht, ci fa vedere dei figli che si sforzano di interpretare padri assenti, a stento conosciuti, mettendosi addosso stracci che potrebbero essere loro appartenuti e tentano di “diventare” come loro. Ce li mostrano stremati dalla fame, che sbavano come lupi, facendo slurp slurp come nei fumetti raccapriccianti di Mauss, li fanno diventare mosche sul cadavere dell’uomo grasso Puffi, bambini cattivi che imitano la sirena del campo e il rumore del gas con la bocca, ballerini lanciati in un charleston sulle note di “Yes, we have no bananas”, pecore belanti portate al macello. Il tentativo di “restituire” quella realtà, pare dire l’autore, è sempre fallimentare: dietro agli sforzi dei figli risuona il ghigno beffardo della Storia e la distanza della Tragedia. Nel 68 quando questo testo fu presentato in America, alla critica non piacque granchè. Si parlò di eccesso isterico, di scandalo e non furono in pochi, ebrei e non ebrei, ad alzarsi e ad andarsene durante le repliche. Perché Tabori aveva rotto un tabù. Nel suo teatro del dolore, il dolore trovava nuove maschere per colpire lo spettatore, anche quelle del comico e della beffa. Personalmente ho trovato questo testo straordinariamente attuale e necessario, in un momento in cui, malgrado le giornate della memoria e le coraggiose iniziative di chi sente il dovere di combattere un revisionismo strisciante, l’olocausto rischia di diventare clichet e dejà vu e “il teatro dell’olocasuto” di divenire genere. Tabori non chiede al pubblico di assistere ad uno spettacolo, gli chiede di esserci, di partecipare al rito con le budella e il pelo pubico: il riso è un modo per tenere lo spettatore sveglio, per non farlo crogiolare nel buonismo e nella retorica, per dirgli “eccoti in scena, guardati, rispecchiati nella tua orribile umanità”.